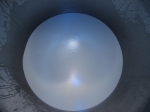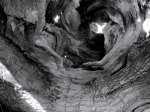dicembre 30th, 2014
I formaggi in miniera.
Oggi siamo in Friuli Venezia-Giulia. Il paese è Socchieve; il paesaggio: la Carnia. Le coordinate geografiche sono 46°23’ Nord e 12°50’ Est.
Arrivo all’uscita Carnia-Tolmezzo che è notte fonda. Decido di fermarmi qui, in un albergo che spunta come un fungo subito dopo il casello autostradale. Altrove sarebbe un motel. Però la stanza è pulita e silenziosa, il materasso rigido come un sasso. Sarà una notte serena. Un unico pensiero mi assilla e mi tiene sveglio: nella sceneggiatura ho scritto che «in Carnia non si viene, si entra». Una frase breve; poche parole che racchiudono con esattezza lo spirito di questo luogo remoto e selvaggio. Le montagne della Carnia sono ripide come muri e tagliate da gole strette e profonde come fiordi norvegesi. Mi addormento nel timore che non sia così facile trovare queste pareti verticali e queste gole strette; forse impiegheremo ore per filmare ciò che ho scritto in qualche secondo.
Al mattino la sveglia suona presto: fuori è ancora buio. Il tempo di una doccia e la luce non si è ancora distesa sul paesaggio che ricordavo piatto e autostradale.
Apro la finestra ed è ancora buio. Non proprio buio: scuro, piuttosto. Quel tipo di penombra che si crea – anche in pieno giorno – di fronte a un muro di roccia verticale.
In Carnia non si viene, si entra!
L’ingresso dell’albergo è affacciato sulla piana del Tagliamento, mentre il retro è appoggiato a una montagna aspra, con una scarpata che frana direttamente nella mia camera. L’inizio della sceneggiatura potremmo girarlo anche qui, senza andare troppo lontano. Invece salgo in macchina e mi dirigo verso Socchieve, dove mi aspetta Sante, il casaro protagonista della puntata.
Man mano che si sale, il paesaggio diventa ruvido come si conviene a una terra di frontiera. Una parete a destra, una parete a sinistra, la gola al centro. Come una porta. Per entrare, bisogna aprirla.
In Carnia non si viene, si entra.
Quando arrivo in paese, Sante è lì che mi aspetta a lato della strada. Non lo riconosco subito, per via dell’improbabile cappello che ha in testa e che terrà per tutte le riprese. Me l’hanno presentato come una specie di artista dei formaggi, un giovane di talento che sta aprendo una nuova strada al caprino in Italia.
Davide e gli altri sono a Sauris a filmare alcune scene di paesaggio. Sante e io ne approfittiamo per conoscerci meglio. Beviamo un caffè a casa sua. A un certo punto, tira fuori dal frigorifero una ciotola di panna. L’ha appena fatta. Ne metto la punta di un cucchiaio nel caffè, poi ne mangio un cucchiaio intero e un altro ancora; il resto lo lascio a Davide: apprezzerà.
La panna di Sante è come un biglietto da visita, l’accordo svisato di un grande chitarrista all’inizio del concerto. Poche note buttate lì: si ascoltano e non si dimenticano.
In attesa degli altri, Sante mi accompagna con il furgone in montagna, per mostrarmi alcuni luoghi dove potremmo mettere la sedia di Davide. Non c’è neve, per fortuna, ma in compenso c’è da attraversare un ponte sul Tagliamento largo come una macchina. Quindi stretto, molto stretto! Se ci fermassimo per un guasto, dovremmo scendere dai finestrini.
Il Tagliamento è il più importante dei fiumi alpini: un dedalo di canali che s’intrecciano lungo una distesa di ghiaia. Dall’acqua affiorano isole ricche di vegetazione che sembrano frammenti di boschi staccati dalla terraferma e naufragati nel corso del fiume. Un paesaggio lunare, con una massa di sassi rotolati tra l’acqua e la montagna. I campi e i sentieri sono delimitati da muretti a secco che i vecchi costruivano a mano, con i sassi del fiume. Sante me ne mostra alcuni – perfetti – che devono avere centinaia di anni; poi me ne indica altri, appena fatti e già in parte franati. Le pietre sono le stesse. È la mano dell’uomo che nel tempo deve essere cambiata.
Seguiamo una strada sterrata ripida che giunge nei pressi di un’ampia radura. Da qui si domina la valle e il borgo di Socchieve, con la suggestiva Pieve di Castoia, una chiesa dalle origini molto antiche e poi ricostruita nel ‘700 in seguito a un terremoto.
Nel frattempo, Davide e Massimo sono scesi da Sauris e ci aspettano a casa di Sante. Probabilmente sono davanti alla ciotola di panna fresca. Ripercorriamo il ponte da brivido sul Tagliamento e ritorniamo a Socchieve, nel laboratorio del casaro.
Sante lavora il latte crudo delle sue capre di razza Sarda e delle vacche Pezzate Rosse Italiane. Mi spiega che le capre Sarde sono molto rustiche e selvatiche. Devono essere munte con una tecnica particolare, praticamente catturandole ogni volta e montando a cavalcioni dell’animale. Abituate ai climi aridi, producono poco latte di altissima qualità, molto gustoso, ricco di proteine e acidi grassi.
Sante scarica il latte dal furgone e lo porta nel laboratorio. Davide si avvicina alla vasca di lavorazione, guarda nella macchina da presa e spiega che il latte crudo è un alimento vivo, diverso ogni giorno: per lavorarlo bisogna prima capirlo.
Come ogni artigiano del gusto, Sante rispetta la tradizione ma cerca sempre di mettere qualcosa di sé in ciò che fa. Adesso sta creando la sua ricotta, un prodotto dalla cremosità eccezionale. Mi domando quale sia il segreto di tanta morbidezza.
– La temperatura.
– La temperatura?
– Tutti lavorano il latte a temperature troppo alte, – dice Sante. – Per me è un errore scaldarlo così…
Capisco che per lui scaldare il latte sia un po’ come ucciderlo, sciogliere quella parte viva, morbida e cremosa che sarà l’anima della sua ricotta. Davide e io la gustiamo come due bambini, golosamente nascosti su una catasta di legna.
Ma intanto, il casaro sta versando nelle forme un caprino a crosta lavata. Il segreto di questo formaggio è invece la stagionatura.
Carichiamo le forme sul furgone e saliamo di nuovo verso i monti. Destinazione Tarvisio, Cave del Predil. Arriviamo con il buio. Le cave dismesse sono chiuse, ma il guardiano viene ad aprirci la sbarra. Comincia a piovere. I fari delle macchine illuminano un paesaggio surreale: sembra la scena di un film di spionaggio, dove i buoni affrontano i cattivi e trattano lo scambio di un ostaggio tenuto per mesi nelle viscere della terra.
Noi, che siamo i buoni, accendiamo le torce e nelle viscere della terra portiamo il formaggio a stagionare. Qui resterà alcuni mesi, con un’umidità costante del 90%, temperatura ideale, aria fine e assenza di acari. Trovo che l’idea di usare una miniera per affinare il formaggio sia geniale. Mi domando come sia venuto in mente a Sante e quando glielo chiedo, lui mi parla diun fortino della Seconda guerra mondiale con stanze sotterranee che sembrano cantine. Vorrebbe farci degli esperimenti. Sta chiedendo i permessi…
Appendiamo alle pareti della grotta le ceste dei caprini freschi e prendiamo quelli già stagionati. Sante li prepara in appositi contenitori. Una piccola parte la prendiamo noi che questa sera siamo ospiti nella cucina più bella del Friuli, a Corno di Rosazzo. Siamo ospiti di Paolo e Walter, due grandi personaggi della regione. Ma questa è un’altra storia, un’altra puntata della nostra trasmissione, dove la Ribolla gialla diventa spumante.
Bene, ora è tempo di andare. Ci aspettano altri paesi e altri paesaggi.
Venite nella Carnia, ma non come turisti – mi raccomando – come ospiti!
Clicca qui per leggere l’articolo pubblicato su mentelocale.it